L’economia sociale come attore di innovazione: la sfida del lavoro
L’ispirazione me l’ha data anche lui. Un classico manifesto 6×3 piazzato lungo la freeway che collega l’areoporto di Johannesburg alla sede della accademia su economia sociale e solidale organizzata (come sempre molto bene) dal centro internazionale di formazione dell’ILO. Giunta alla sua quinta edizione l’accademia metteva al centro un tema – l’innovazione sociale nel mondo del lavoro – molto semplice nella formulazione, ma assai complesso nella trattazione. Se è vero infatti che l’innovazione sociale è un passepartout con cui aprire molte porte è altrettanto vero che, una volta aperte, occorre saperle trattare come temi di ricerca, cogliendone le implicazioni in termini di reale mutamento e non solo per seguire i “twist and turns” della politica.
Un rischio che, forse, correva anche il manifesto stradale. Centrato  sull’innovazione sociale come brand che qualifica, o meglio rigenera, il business non di una impresa dell’economia sociale e solidale ma quello di un player globale dell’industria meccanica. Tanto che verrebbe da degradare il tutto al rango di mero riposizionamento dell’economia capitalistica su tematiche alla moda, utili a sostenere politiche di comunicazione della Csr. Sarebbe però un errore madornale, perché in ballo ci sono questioni ben più complesse che chiamano in causa la ristrutturazione profonda delle catene di produzione del valore, sempre più chiamate – per essere competitive – a incorporare fattori di socialità e sostenibilità ambientale. Non questioni da trattare come mere “esternalità positive”, ma come componenti strutturali di nuovi business model.
sull’innovazione sociale come brand che qualifica, o meglio rigenera, il business non di una impresa dell’economia sociale e solidale ma quello di un player globale dell’industria meccanica. Tanto che verrebbe da degradare il tutto al rango di mero riposizionamento dell’economia capitalistica su tematiche alla moda, utili a sostenere politiche di comunicazione della Csr. Sarebbe però un errore madornale, perché in ballo ci sono questioni ben più complesse che chiamano in causa la ristrutturazione profonda delle catene di produzione del valore, sempre più chiamate – per essere competitive – a incorporare fattori di socialità e sostenibilità ambientale. Non questioni da trattare come mere “esternalità positive”, ma come componenti strutturali di nuovi business model.
Messa in questi termini, l’innovazione sociale assume una rilevanza centrale nel discorso sui processi di cambiamento e, in specifico, sulle forme di organizzazione del lavoro e sul ruolo che può assumere l’economia sociale e solidale. A patto però che quest’ultima sappia rigenerare, essa stessa, la “meta competenza” specifica legata alla capacità di introdurre gli elementi di valore che sostanziano la propria missione (educazione, inclusione, cura, ecc.) all’interno di contesti diversi da quelli del welfare tradizionale. In parole povere: produrre impatto sociale non solo con le risorse redistribuite dallo Stato e dalla filantropia, ma anche attraverso economie autenticamente sociali dove, a questo punto, ha senso prevedere un ruolo per la finanza d’investimento. Qualche esempio? Utilizzare l’agricoltura per innovare le politiche sociali (quando si dice “andare fuori dal seminato”), oppure produrre cultura per innovare le politiche di real estate, rigenerando spazi e beni immobili come asset comunitari; e ancora ripensare le politiche di sicurezza (un tema cruciale in un contesto come quello sudafricano) investendo su progetti di coesione sociale innervati da enabling technologies che puntano sullo sviluppo di socialità e non sul “controllo del territorio”.
Trovare nuovi “access point” per inoculare innovazione sociale nei sistemi economici rappresenta quindi la grande sfida per le organizzazioni di economia sociale e solidale. Una sfida non priva di rischi – anche perché chiama in causa alcuni tabù del settore come la scalabilità oltre l’esperienza localizzata – ma ineluttabile stante il livello delle sfide sociali e ambientali (la cui soluzione non è più rinviabile) e, al fondo, guardando alla missione di interesse generale di questi soggetti che li spinge ad uscire dalla nicchia settoriale e giuridica nella quale, alle volte, amano rinchiudersi.
Da questo punto di vista, una importante “exit strategy” è rappresentata proprio dal fattore lavoro. Un terreno di confronto su una sfida cruciale – soprattutto per alcune fasce della popolazione: femminile, giovanile – che nel campo dell’innovazione sociale è monopolizzata da una retorica che fa perno su fattori quali: il ruolo dell’imprenditore come figura “eroica” anche in campo sociale; la sfocatura dei confini tra ambiti istituzionali e forme organizzative (profit-nonprofit, pubblico-privato); il carattere discontinuo (“disruptive”) delle innovazioni (anche sociali) rispetto alle soluzioni pre-esistenti.
Cosa offre quindi l’economia sociale e solidale, non solo in termini di creazione di posti di lavoro, ma, più in generale, di nuovi modelli di lavoro e di produzione? Anche in questo caso emergono alcuni temi rilevanti. Il primo riguarda il carattere collettivo del 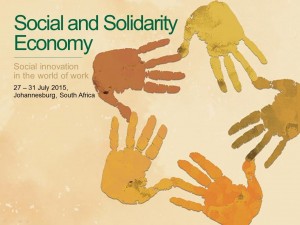 lavoro e dell’intrapresa; un aspetto tutt’altro che marginale in un’epoca storica che enfatizza i caratteri di socialità, condivisione, cooperazione. Il secondo elemento consiste nel sense-making trasformativo dell’esperienza lavorativa, ovvero nella consapevolezza di star operando, anche attraverso una micro attività, per un cambiamento sostanziale delle forme e dei mezzi della produzione economica. Infine per l’economia sociale e solidale l’esperienza lavorativa è strettamente legata alla governance organizzativa, nel senso che comunità di produttori, consumatori e forme miste (prosumers) si costituiscono anche intorno al possesso (e all’esercizio) di diritti di proprietà su imprese che si dotano a tal fine di assetti di governance inclusiva. Certo la messa a sistema di questi elementi di innovazione istituzionale è legata alla necessità, ormai inevitabile, di dar vita a nuove forme organizzative ma soprattutto di disegnare un nuovo campo di interazione, apprendimento e cross fertilization.
lavoro e dell’intrapresa; un aspetto tutt’altro che marginale in un’epoca storica che enfatizza i caratteri di socialità, condivisione, cooperazione. Il secondo elemento consiste nel sense-making trasformativo dell’esperienza lavorativa, ovvero nella consapevolezza di star operando, anche attraverso una micro attività, per un cambiamento sostanziale delle forme e dei mezzi della produzione economica. Infine per l’economia sociale e solidale l’esperienza lavorativa è strettamente legata alla governance organizzativa, nel senso che comunità di produttori, consumatori e forme miste (prosumers) si costituiscono anche intorno al possesso (e all’esercizio) di diritti di proprietà su imprese che si dotano a tal fine di assetti di governance inclusiva. Certo la messa a sistema di questi elementi di innovazione istituzionale è legata alla necessità, ormai inevitabile, di dar vita a nuove forme organizzative ma soprattutto di disegnare un nuovo campo di interazione, apprendimento e cross fertilization.
È questo, in sintesi, il progetto di “open cooperativism” che, riprendendo le parole di Michel Bouwens, it means concretely working on the creation of entrepreneurial coalitions that are co-dependent and organized around the commons that they are co-creating. Una sfida che esperienze come quella sudafricana possono certamente aiutare a perseguire.
Link: ILO Academy
